

Parrocchia Prepositurale Collegiata
Diocesi di Milano - Zona Pastorale IV - Busto Arsizio (Va)













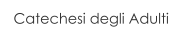

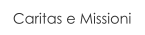

© Parrocchia Prepositurale Collegiata San Giovanni Battista
Via Tettamanti 4 - 21052 Busto Arsizio (Va) - tel.0331.638232 - email: parroco@bustosgb.it

AIUTA LA TUA PARROCCHIA : Codice IBAN: IT 10 F 03069 09606 10000006 2310


















Oratorio
San Luigi
seguici su
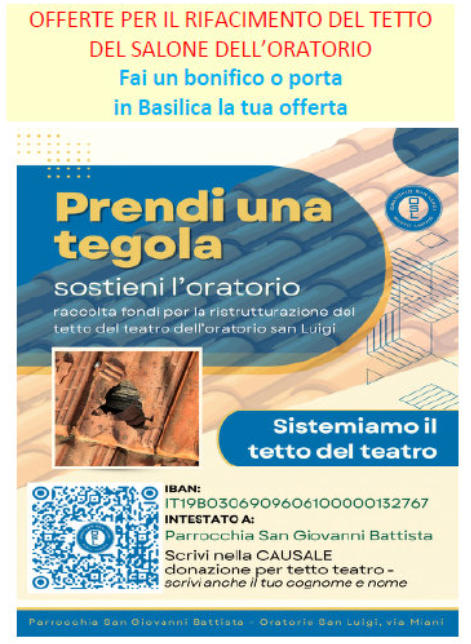


“La compassione del Samaritano:
amare portando il dolore dell’altro”.
leggi il messaggio di Papa Leone XIV >>>
10 FEBBRAIO
ore 18.30 Messa in S. Maria
in apertura del “Punto salute”
11 FEBBRAIO
FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES
07.00 e 08.00 S. Messa in S. Maria
16.00 Rosario e S. Messa in S. Maria
con Unzione degli Infermi
Alle 18.30 la S. Messa è sospesa

DON ISIDORO MESCHI,
«UOMO DI SPERANZA»
Celebrazione eucaristica in memoria
presieduta da
Sua Ecc.za Mons. Franco Brambilla
Vescovo di Novara
Venerdì 13 febbraio alle ore 21.00
in Basilica

dal 10 al 16 febbraio 2026
si svolgerà la 26ª edizione delle
Giornate di Raccolta del Farmaco
di Banco Farmaceutico.
Per partecipare a questo gesto di carità,
si può andare nelle farmacie che aderiscono e
acquistare uno o più medicinali da banco
per i bisognosi, che saranno consegnati agli enti
caritativi del nostro territorio.
Invitiamo i fedeli e i collaboratori
delle Parrocchie di Busto
a recarsi sabato 14 febbraio presso la
Farmacia Borsano di viale Boccaccio 96
dove saranno raccolti farmaci
da destinare a PUNTO SALUTE
il recente ambulatorio costituito
dal decanato di Busto Arsizio in
collaborazione con la Croce Rossa Italiana
Per adesioni e informazioni: 340 740 01 59
Banco Farmaceutico Busto Arsizio

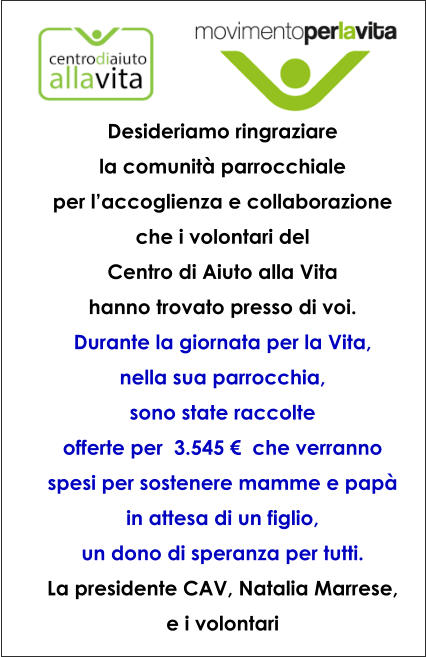

Lunedì 9 febbraio alle 20.45 a Stoà
Incontro 18/19nni del decanato
Riflessione con tutti i ragazzi della città
di Busto Arsizio, sul tema della scelta
